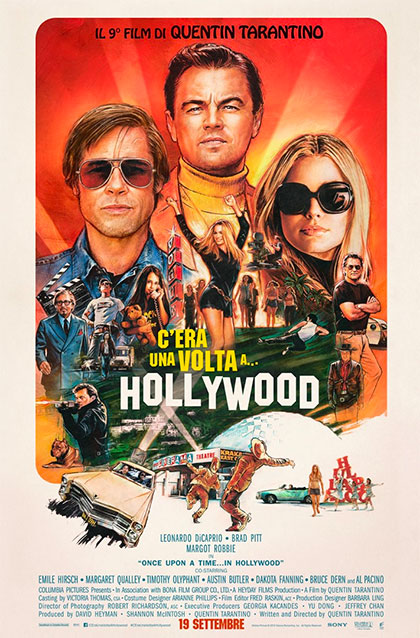Quando si parla di cinema sperimentale, solitamente c’è un particolare film che mi ritorna alla mente, e quando fra nuovi conoscenti ci si ritrova a consigliarsi le pellicole preferite, quelle che più ci hanno emozionato, o sapete, di quelle che improvvisamente piombano nel momento giusto del vostro percorso, all’età giusta, pronte ad aprivi gli occhi su chissà quale scomparto del mondo sconosciuto, ecco che ancora una volta è alle immagini di “Waking Life” che penso.
Sono incappato nel film di Richard Linklater (“Boyhood” e la trilogia “Before”) durante i primi anni del liceo, in un periodo in cui ero alla ricerca di qualcosa che riuscisse a soddisfare una mia particolare curiosità e attrazione per il mondo onirico, e soprattutto per il “sogno lucido”. Questo è un eccentrico fenomeno psichico, una condizione del sonno in cui il soggetto ha modo di sperimentare la consapevolezza del dormire e, teoricamente, avere la capacità di modellare la forma e la sostanza del proprio sogno, con tutte le infinite possibilità che ciò può comportare. Mi dicevo, “il presupposto narrativo per chissà quante storie, quante opere”, e “Waking Life” riusciva a cogliere in maniera del tutto originale e profonda il potenziale di un simile concetto.
Il film racconta di un giovane ragazzo intrappolato in un sogno lucido, alle prese con una realtà completamente distorta, alla mercé di casuali incontri con stravaganti personaggi, nei luoghi più comuni, dal ciglio di una strada californiana al bancone di un offuscato pub, ad un accogliente salotto di famiglia.
E così seguendo la danza tragica del sognatore nel suo tentativo di risveglio, scopriremo come ognuna di queste persone ha qualcosa da dire al nostro protagonista: un’enigmatica poesia o una bizzarra teoria sull’origine della coscienza umana, una dedica alla folle casualità dell’esistenza o una genuina riflessione sulla rabbia, la comunione, la sacralità. Ben presto ci si accorgerà infatti che il motore del film sono il linguaggio utilizzato, l’espressione e il dialogo fra queste identità che si incontrano.
Lungi dal risultare una mera compilazione di astrazioni e discorsoni, “Waking Life” è semplicemente un sincero ed esplicito sguardo su diversi aspetti della vita umana, ognuno dei quali viene esternato e incarnato allo stesso tempo da un uomo o una donna diversi, estremamente capaci di calarsi nei panni del “guru”, del rivelatore, del suggeritore di turno. Le dichiarazioni dalle quali il ragazzo si lascia trasportare, sono espressione di ammirazione verso il mondo e al contempo tentativo di indagarlo e spiegarlo al prossimo che vorrà
ascoltare. É anche qui l’originalità della pellicola, nel chiedere direttamente allo spettatore di ascoltare, più che osservare, non distrarsi ma prestare attenzione. Prestare attenzione e accorgersi che il casuale e innocuo discorso di un passante può celare al suo interno un universo di simboli, segni, tracce di esperienze e vissuti, orizzonti e prospettive future nel quale potersi riconoscere.
Non che l’aspetto estetico del film sia da meno, dato che l’autore ha optato per la tecnica del “rotoscope”, mettendo in forma di disegno a mano tutte le scene precedentemente girate, e in piena libertà artistica scegliendo i colori, le sfumature, gli schizzi e guizzi, che più si confacevano all’animo e sentimenti dei personaggi.
Difficile da descrivere a parole, l’esperienza di un’opera del genere non può che arricchire la mente dello spettatore, fornendogli molteplici chiavi di lettura della propria quotidianità, facendo capire come in fondo senza il dialogo e la comunicazione con l’altro non si potrebbe mai essere sé stessi, non si potrebbe mai crescere e maturare. “La vita da svegli (waking life) è un sogno sotto controllo” affermava un filosofo spagnolo, Santayana, per cui mi verrebbe da chiedermi, ribaltando la logica del sogno lucido:”Cosa accadrebbe se un giorno ci accorgessimo piuttosto di essere svegli?”.
Tommaso Lonzar